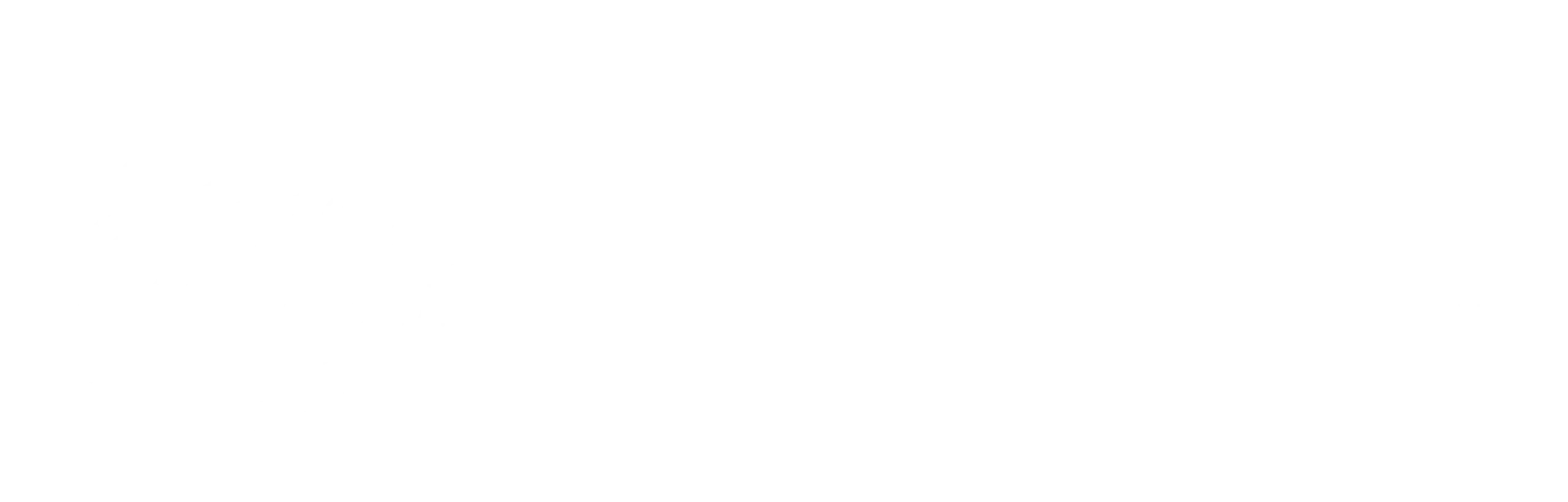Vera Gheno a "Mi Prendo il Mondo"
«È molto difficile rimanere democratici se le persone manco capiscono quello che il governo, per esempio, dice loro»
A margine della rassegna “Mi prendo il mondo” 2026, ho avuto l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Vera Gheno, sociolinguista, accademica e traduttrice. Il suo ultimo volume, Nessunə è normale, disarticola il concetto di normalità, sottolineandone l’autoreferenzialità, cioè come rappresenti una norma che aderisce a se stessa.
Nel corso dell’intervista (la mia prima in assoluto!), Gheno ha ripercorso l’iter che l’ha condotta a ragionare su questo tema, offrendo, poi, un vivido spaccato sul suo lavoro da podcaster, sulla sua esperienza all’Accademia della Crusca e sul suo rapporto con le lingue straniere, in modo particolare con l’ungherese.
Nel suo ultimo libro, Nessunə è normale, lei compie una panoramica sulla normatività del termine normale. Da cosa nasce questa sua necessità di ricerca e approfondimento?
Penso di essere partita banalmente dai temi cardine del femminismo: la relazione tra maschile e femminile, la presenza femminile nella lingua e così via. Però poi molto presto ho sposato l’idea che occorra avere uno sguardo intersezionale, cioè far caso un po’ a tutte le dimensioni umane che espongono una persona a una possibile marginalizzazione, quindi età, sesso biologico, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, neuroatipicità.
Se uno pensa in maniera intersezionale, alla fine si rende conto che al di là della singola dimensione di discriminazione, quello che tendenzialmente si emargina nella nostra società è il diverso rispetto al normale. E allora la domanda per me è stata abbastanza naturale: come si costruisce l’idea di normalità? Chi è normale? È evidente che anche qui in Italia ci sono dei canoni di normalità ben precisi, quindi è normale essere bianchi, eterosessuali, non avere disabilità, essere neurotipici. Che cosa implica allora nei confronti di tutte le persone che non sono fatte in questo modo? E soprattutto, quanto è mobile il principio della normalità, quanto posso decidere se includere o escludere una certa minoranza dal mio concetto di normalità? È stato tutto abbastanza organico, non è che ci ho dovuto pensare più di tanto.
Nel suo libro fa molto spesso riferimento all’opera di Tullio De Mauro: qual è l’eredità di questo grande linguista per la società contemporanea?
Tullio De Mauro è stato storico della lingua, linguista, sociolinguista, etnografo e chi più ne ha più ne metta, è stato una figura a tutto tondo nell’ambito della linguistica, e non solo.
Penso che uno dei suoi lasciti maggiori sia il principio dell’educazione linguistica democratica, ossia della conoscenza linguistica come mezzo per preservare la democrazia. In sostanza quello che lui dice, attraverso tanti anni di lavoro, è che abbiamo bisogno che le persone abbiano una salda competenza linguistica proprio per garantire la sopravvivenza della democrazia.
È molto difficile rimanere democratici se le persone manco capiscono quello che il governo, per esempio, dice loro; ecco, quindi, l’importanza di lavorare sulla lingua, che non è semplicemente fare bella figura e conoscere i congiuntivi, ma è far sopravvivere la democrazia stessa. Questo credo che sia qualcosa di assolutamente attuale. Tra l’altro, De Mauro prende a piene mani da don Milani, da Gramsci, da tutta una lunga tradizione che oggi, per fortuna, si unisce anche a studi stranieri: mi viene in mente Freire o bell hooks – che oggi è stata un po’ riscoperta – quindi tante persone parlano di questi temi. Credo che per l’Italia, De Mauro l’abbia fatto meglio di tutti gli altri.
Lei cura, per Il Post, il podcast Amare parole: come sceglie l’argomento da trattare nei vari episodi?
Purtroppo, nella maggior parte dei casi, basta guardare a quello che succede nel mondo. È un podcast settimanale, quindi vuol dire che appena dopo aver registrato la puntata, di solito massimo il giovedì, già inizio a considerare se c’è qualcosa che, in maniera magari specifica, ha a che fare con le parole. In questo momento, per esempio, uno dei temi che avrei avuto piacere di affrontare è la lettera di Trump al premier della Norvegia. Succede, però, molto spesso che mi ritrovo a dover fare le cose di corsa, perché per studiare per una puntata un po’ di tempo ci vuole; talvolta mi concentro su un tema che riesco a trattare in maniera un po’ più concisa, anche per evitare di dire delle sciocchezze. Una cosa che considero sempre è che il podcast esce dopo una settimana; pertanto, è un po’ un cold case: magari, nel frattempo, tante altre persone molto più competenti di me hanno detto la loro, il bisogno di commentare è scomparso, allora mi invento qualcos’altro. Però, ecco, basta guardarsi attorno, ahimè.
Per lungo tempo ha collaborato con l’Accademia della Crusca: che ricordi ha di quel periodo?
Ho lavorato vent’anni per l’Accademia della Crusca. Sono entrata poco più che ventenne e sono uscita a poco più di quaranta: nella vita di una persona è il momento della crescita. Forse per me i ricordi più belli sono state le ore molto tranquille spese a lavorare in mezzo ai libri. In particolare, a lungo l’ufficio nel quale stavo era nel “fondo Migliorini”, che erano i libri di Bruno Migliorini, altro grande linguista. Io non penso mai che esista l’osmosi culturale, però il fatto di stare nel mezzo dei libri di un accademico di questo spessore l’ho sempre trovato molto di ispirazione.
Un altro ricordo?
Nella grandissima Biblioteca della Crusca, alla quale all’epoca avevamo accesso libero, c’è una sezione che è quella degli incunaboli, che sono i libri sui quali gli Accademici della Crusca hanno studiato per scrivere la prima impressione del vocabolario del 1612. Stiamo parlando di testi molto antichi. Ogni tanto, soprattutto quando ero agitata o non riuscivo a lavorare, mi infrascavo nella sezione degli incunaboli a “sniffarli”, perché i libri antichi hanno un odore tutto loro, dovuto al fatto che sono realizzati con carta fatta con cotone, non cellulosa. Una carta che dura molto di più. Lì ci sono dei testi del Seicento che sono molto meglio conservati dei gialli degli anni ‘70 dei miei genitori. Ecco, sniffare libri antichi è uno dei ricordi della Crusca che mi porterò per sempre dietro.
Lei è traduttrice dall’ungherese: come approcciarsi a una lingua ritenuta generalmente così complessa, con un numero enorme di casi grammaticali?
Considerato il principio che “ogni scarrafone è bello a mamma soia”, è la mia lingua madre, quindi non ho dovuto studiarla. Ho una preparazione formale bassissima sull’ungherese, perché l’ho studiato pochissimo come grammatica, però lo parlo e lo frequento in quanto madrelingua. Non so come ci si approcci a un idioma così lontano dal proprio. Posso dire che si può imparare l’ungherese, mio padre lo ha insegnato per tutta la sua carriera universitaria. Sicuramente hanno un vantaggio coloro che sono bravi a sentire i suoni di un’altra lingua, a riprodurli, che non è assolutamente banale. Per dire, sono nata in una cittadina che si chiama Gyöngyös, e già questo gyö, per la maggior parte degli italiani è insormontabile, anche se ci si impegnano. Però si può fare, le corde vocali si possono esercitare. E per i casi grammaticali, beh, una volta che capisci come funziona il sistema, più o meno te la puoi cavare.
E con le altre lingue?
A dir la verità, non so come si imparano le lingue. Ho avuto la fortuna di impararne quattro-cinque da adolescente, e da grande ho provato a studiarne altre, per esempio il bahasa, l’indonesiano, perché sono stata per un periodo in Indonesia. Più recentemente il sudcoreano, perché mia figlia lo sta studiando: è una fissata del K-pop e della hallyu, la new wave coreana. Io, in tanto tempo, in anni, ho imparato a dire solo “grazie”, “arrivederci” e “ciao”, tutto il resto mi sembra insormontabile.