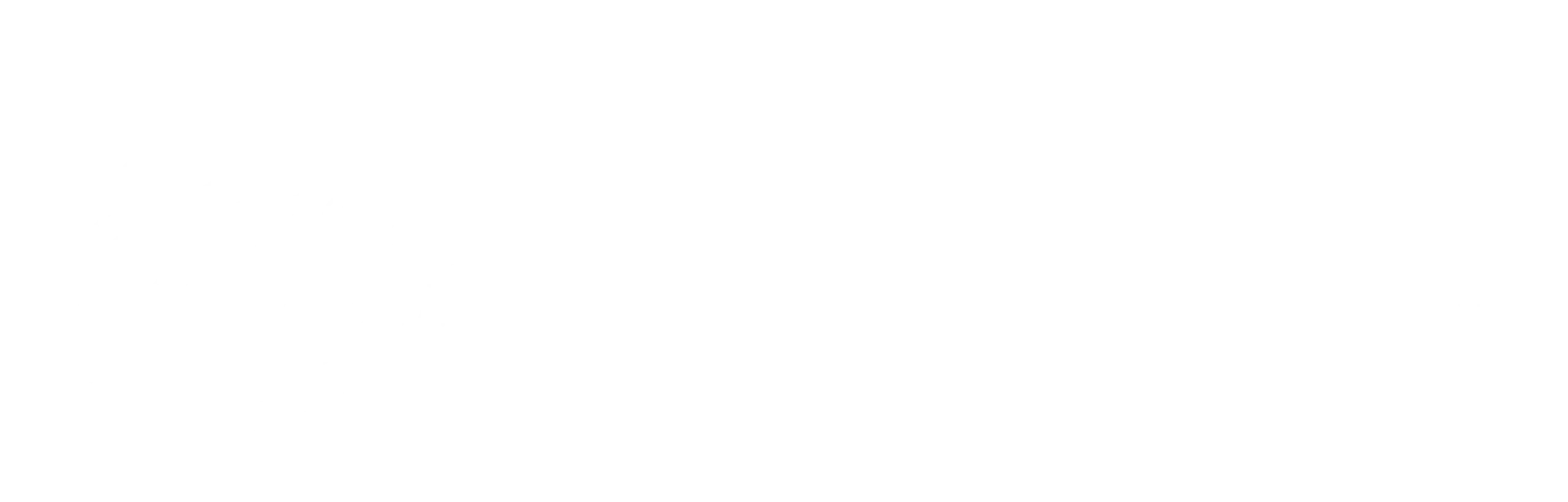«Considerate questo: mentre sono seduta qui con voi, l’Iran è sull’orlo di una rivoluzione. È un massacro, una barbarie. Non riesco più a contattare i miei cari».
Il gelo cala sulla sala del Paganini Congressi, per l’edizione 2026 della kermesse “Mi prendo il mondo“; è come se nella mente di ognuno si palesassero le immagini delle proteste nel Paese, orrendamente represse nel sangue. O, perlomeno, ciò che riesce a trapelare dai confini, poiché il regime ha imposto un blocco totale di Internet. Una brutalità inenarrabile, che le parole riescono a malapena a dipingere. Ma Shirin Neshat, quelle parole le trova: sono nette, severe, non concedono sconti.
«Sono nata in un piccolo villaggio, una comunità molto religiosa, già prima dell’arrivo di Khomeini. Mio padre, un intellettuale, amava viaggiare ed era ateo; pertanto, fin da piccola ho sperimentato una sorta di distacco rispetto alla collettività. Una separazione che spesso ingenerava in me un senso di colpa».
Un’incomunicabilità, quella tra individuo e gruppo, che ritroviamo in molte sue installazioni video, come Turbulent (1998). Nella sua concezione originaria, l’opera dev’essere proiettata su due muri opposti: da una parte, un uomo si esibisce in un canto popolare dinanzi a una platea di soli uomini, dall’altro lato una donna fronteggia un parterre vuoto, modulando una serie di suoni inintelligibili, rompendo le regole della tradizione.
«In Iran, alle donne non è consentito cantare», spiega Neshat.
Non è dettata dal caso la scelta di giustapporre un uomo e una donna «Noi iraniane siamo oppresse dalla guerra, ne siamo vittime, ma allo stesso tempo siamo guerriere, eroine, radicali, non ci tiriamo indietro. Per me questo vuol dire essere donna, in contrapposizione alla maschilità, che spesso rappresenta il conformismo».
La riflessione artistica di Shirin Neshat è costellata da contrasti, antitesi «Lavoro sui conflitti: dolore-amore, libertà-morte, perdita-gioia, violenza-misticismo. Per tale ragione, impiego prevalentemente il bianco e nero – tranne per il sangue, che è sempre un’eccezione – poiché solo queste due tonalità sono in grado di trasmettere un senso di contraddizione. Il colore è troppo bello». La sua versione di Orfeo ed Euridice si inserisce coerentemente in questo filone di ricerca «Si è trattato di un esperimento, della volontà di trovare un punto di contatto tra vari media: l’opera, il cinema, la fotografia, la musica. A differenza del libretto di Gluck, ho voluto però ampliare il ruolo di Euridice, narrare il dramma di una donna che ha perso un figlio. Non sono molto a mio agio con gli happy ending, il mio lavoro attinge a piene mani dalle tragedie». Un’interpretazione, anche questa, spiccatamente politica «Nell’elemento demoniaco dell’opera io rivedo le nefandezze dei militari della Repubblica Islamica».
Shirin Neshat riflette anche sulla sua traiettoria umana e professionale: «Non sarei l’artista che sono se non avessi vissuto la vita che ho vissuto. Dopo gli studi, ho interrotto per diverso tempo la mia attività, perché mi era impossibile concepire un’arte fine a sé stessa, da esporre nelle gallerie», ricorda. «Ma il regime mi ha spinta a ricominciare. Nelle mie opere, parlo solo di quello che conosco in prima persona: in caso contrario, non potrei trattare, a titolo d’esempio, di esilio o di isolamento politico. Per questo sono qui, perché mi sono assunta la responsabilità di produrre opere che parlino dell’Iran di oggi. Non vorrei essere considerata un’artista politica, ma l’essere iraniana me lo impone».