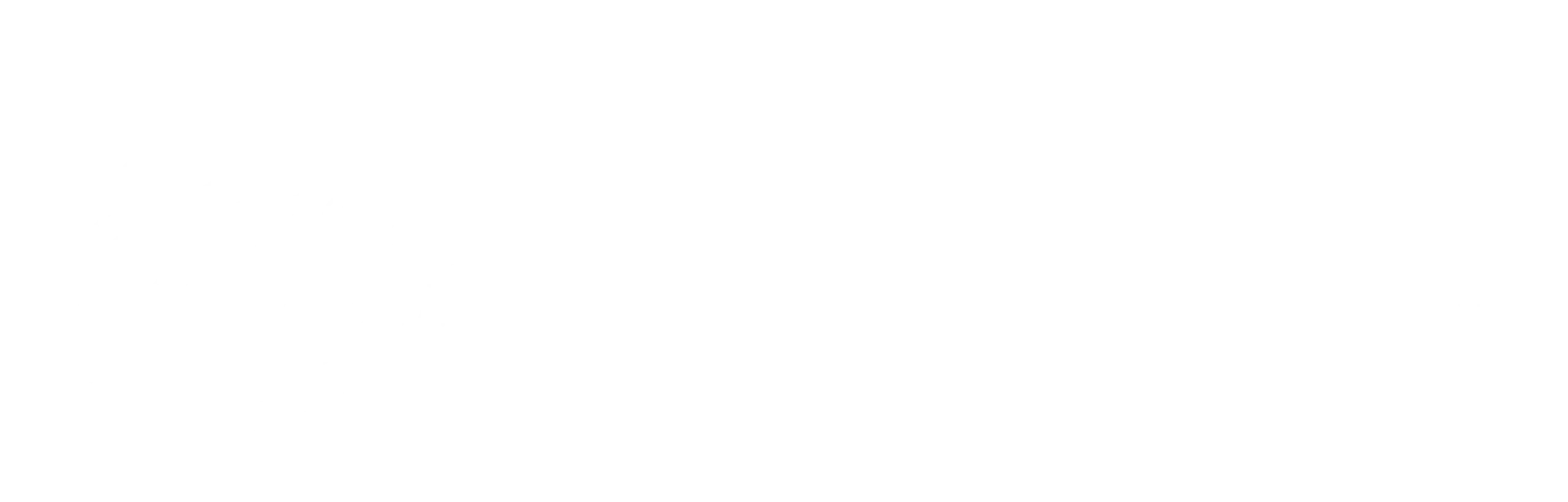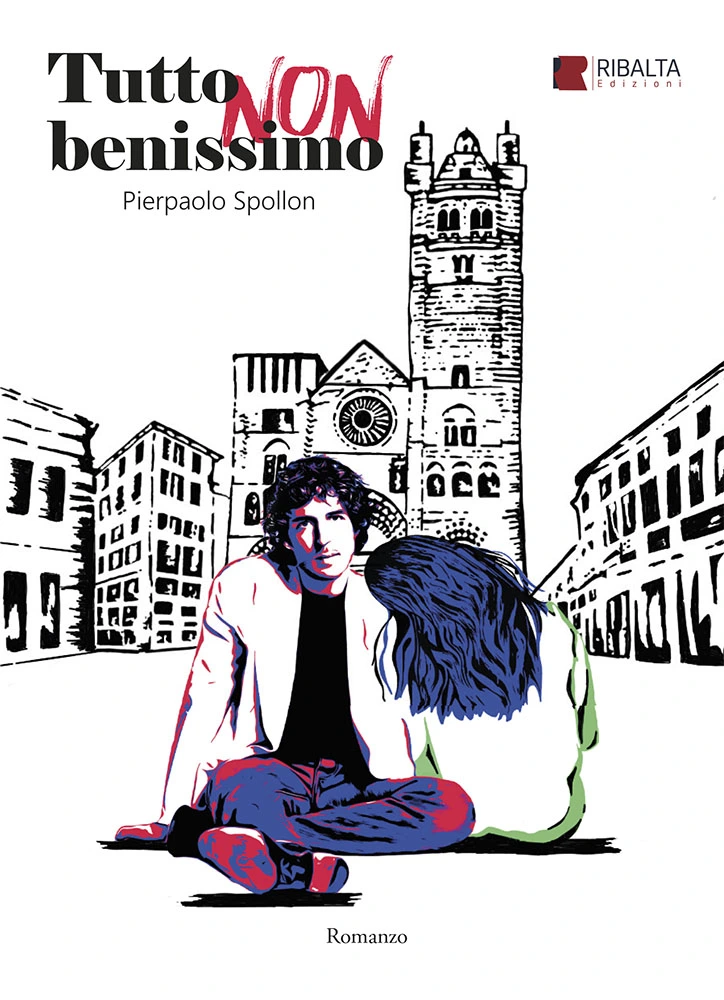
Copertina del libro 'Tutto non benissimo'
La presentazione del libro lo insegue, ma Pierpaolo Spollon è più veloce. Tutto non benissimo (Ribalta Edizioni) diventa in fretta un ottimo pretesto per parlare di «uno dei temi più importanti degli ultimi cinque anni»: le emozioni. E non solo: nell’indecisione di Quel che dir non so, che dà il titolo al suo primo spettacolo teatrale, l’attore padovano trova le parole per dire molto di più. Ormai suoi “ostaggi”, negli spazi dell’Associazione Remo Gaibazzi, i presenti – al penultimo appuntamento del Parma Film Festival 2025 – restano impigliati nel suo disordine ordinato: il suo stream of consciousness. È la giornalista Benedetta Bragadini a tenere le fila del discorso, spalla complice del noto volto di fiction come Doc – Nelle tue mani, Blanca e L’Allieva.
Dopo anni di proposte rifiutate, Spollon accetta di mettersi tra le pagine di un romanzo come scrittore atipico, colto sempre da quella «sindrome dell’impostore» che gli impone di non prendersi mai troppo sul serio. Al suo fianco come co-autore Matteo Monforte, «uno dei quattro uomini presenti in sala», ironizza Spollon, guardando la platea femminile e indicandolo, lo stesso che «aveva come idea geniale quella di mescolare una storia di psicoterapia a Californication, la serie», puntualizza divertito.
In una Genova già familiare ai fan dell’autore si snoda la trama. Lontano dal genere dell’autobiografia, il romanzo si ispira a un attore forse reale (di cui comunque si cela il nome), dallo stile di vita piuttosto disinvolto. A «muovere l’azione» è una donna del passato, che trascina il protagonista in una ricerca interiore inattesa. Tra le vie del centro la intravede per caso, ma non le parla «per mancanza di coraggio». Prova a inseguirla, ma lei presto scompare, lasciando dietro di sé solo una borsa e l’eco della sua assenza. È questa a divenire un enigma, il filo invisibile che lo costringe a confrontarsi con quello che è stato, ma soprattutto con se stesso.
L’intuizione dell’attore nasce dall’eredità di un regista che con le emozioni «aveva un conto aperto»: Joshua Oppenheimer. In una «società a squadre», dove ogni cosa pende da un lato o dall’altro, Spollon ci invita a interrogarci piuttosto che schierarci: dare un nome a ciò che sentiamo, guardare il passato in faccia – come in The Act of Killing – e rimettere a fuoco lo sguardo come in The Look of Silence. Fare i conti con ciò che è stato e con ciò che siamo non diventa solo un gesto rivoluzionario, ma l’unico necessario.
La scrittura per il teatro, a cui il libro è legato a doppio filo, nasce da un’urgenza:
«Tutto parte dalla lettura di un articolo accademico, che diceva che il 70% dei casi di depressione giovanile deriva dal fatto che i ragazzi non sanno riconoscere le proprie emozioni».
Da qui la domanda:
«Qual è la motivazione per cui non ci fermiamo a chiederci ‘che cosa sta succedendo?’».
Se in Italia abbiamo meno termini in cui riconoscerci, in altri luoghi, come il Giappone, anche le sensazioni più sottili hanno una definizione.
«Dare un nome preciso all’emozione toglie dalla confusione, il cervello riesce a elaborarla, a renderla reale», spiega Spollon.
L’attore spezza una lancia a favore della Gen Z: «Io faccio fatica a parlare di politica con i miei coetanei», mentre loro «sono rientrati in piazza per appropriarsi di uno spazio politico che ci aveva allontanati». I social, che avrebbero dovuto connetterci, «fanno l’opposto»: più accesso a tutto, ma biologicamente meno funzioni, e questo incide inevitabilmente sulle relazioni interpersonali. Come dice Luca Argentero, «le signore comprano le poltronissime», eppure il messaggio parla anche ai più giovani, e Spollon tende loro una mano.
L’urgenza di comprendere i cambiamenti intergenerazionali si estende anche a una nuova progettualità teatrale:
«Parlerò della paternità e di come è cambiato il ruolo del padre», ma anche di «come sia cambiato il ruolo del presunto maschio da una volta a oggi e come deve ancora cambiare».
«Sì, spalleggio un po’ le femministe», ammette, «però c’è una cosa che mi ha colpito: come geneticamente e biologicamente stiamo cambiando». Studi recenti mostrano come un padre che passa due mesi con i propri figli abbia «una situazione ormonale sovrapponibile a quella della madre: prolattina alta, testosterone ai livelli femminili…». Si tratta di una scoperta recente che «riscrive la storia» e conferma come non ci sia una differenza tra i generi che non sia culturale.
L’attore racconta un aneddoto d’infanzia legato al film L’ultimo dei Mohicani e confessa: sul finale «piangevo con le convulsioni». Ricorda sua madre sedersi al suo fianco, mentre lui è alle prese con la sua vulnerabilità e lei insiste nel chiedergli perché stesse piangendo. A quella domanda Spollon trova risposta solo dopo (nell’amato rifugio del dottor Pecora). Alla fine il tema delle emozioni passa anche per queste vie, ed è proprio da queste che nascono, talvolta, le riflessioni più stimolanti:
«Se un film può aprire così tanto dentro, quanto sarebbe bello restituire questo regalo agli altri?».
Oggi, quando studia una scena, gli basta guardare il tatuaggio di Daniel Day-Lewis sul braccio per ricordarsi di dare sempre il meglio.
«I film ci emozionano, ma non sempre per quello che raccontano», precisa: si tratta di «qualcosa che proiettiamo». Ciò che sta dentro lo schermo attiva le nostre cellule specchio e noi ci riflettiamo dentro la storia. Lo stesso vale per la musica, che per Spollon diventa «veicolo di emotività».
Ogni sera (o all’incirca 330 giorni l’anno), da più di venticinque anni, prima di dormire ascolta dei brani – spesso di Lucio Battisti – e piange. «E poi mi addormento tranquillo», dichiara, come fosse un rito catartico che lo riconnette a ciò che sente davvero.
Spollon osserva come questa capacità di vivere le emozioni abbia radici antiche: fin da neonati, attraverso il mirroring, impariamo a leggere lo sguardo dell’altro specchiandoci in esso. È lo stesso riflesso primordiale che, più tardi, ci permette di entrare nell’arte: ciò che vediamo o ascoltiamo attiva in noi un’eco emotiva, una risposta che ci fa sentire dall’interno ciò che vive chi abbiamo davanti, anche quando appartiene a un mondo mai vissuto.
Con entusiasmo, curiosità e auto-ironia, Spollon sa ridere di sé stesso senza perdere mai credibilità. È tra backstory meticolose e ricerche fino a tarda notte che ogni iniziativa prende piede, fino a quando una nuova intuizione rimette tutto in gioco. Gli occhi si illuminano mentre racconta degli ultimi vinili acquistati: «Una cinquantina», scherza la giornalista. «Una trentina al massimo», corregge lui, ridendo. Le sue scelte professionali parlano chiaro: dal cinema al teatro, alla piccola casa editrice, tutto è dettato dalla sua esigenza di comunicare.

credits: Parma Film Festival
La stessa coerenza guida la sua riservatezza: la paternità emerge solo quando serve a proteggere l’ascolto del pubblico, non per difesa, ma per cura del proprio progetto.
Ascoltarlo è vedere l’attore che si fa personaggio. Il suo nome diventa aggettivo: ‘spolloniano’ non è più un marchio di fabbrica, ma un modo di essere, dove un’innata leggerezza s’intreccia alla profondità di chi non smette mai di cercare.