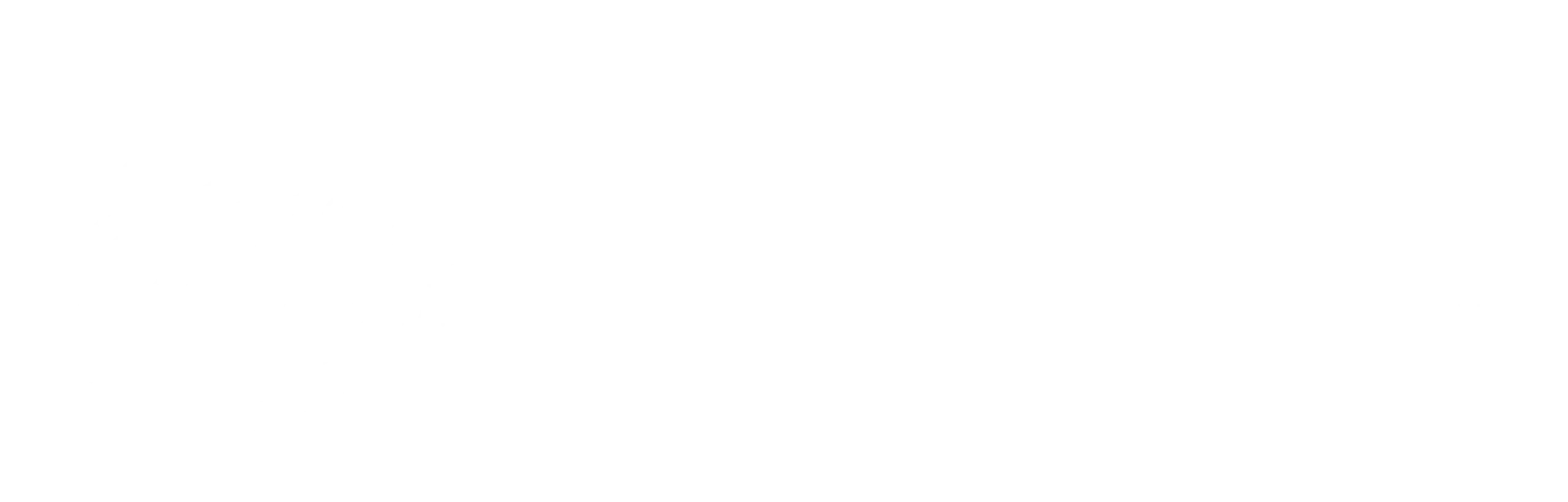Anja Franziska Plaschg alias Soap&Skin e Jason Pierce, frontman degli Spiritualized
Barezzi Festival ci ha portati a spasso col diavolo e poi a fluttuare nello spazio: sabato 15 novembre, Soap&Skin e gli Spiritualized hanno fatto del Teatro Regio un luogo di acuti strazianti, chitarre distorte, intimità e contaminazione.
Soap&Skin
Un singolo fascio di luce dall’alto sembra squarciare in due il palco, racchiudendo in un piccolo cerchio illuminato solo un pianoforte, un microfono e una ragazza dai capelli scuri, vestita di nero e di bianco. Sull’immensa ribalta del Teatro Regio, si intravedono nella penombra anche una grancassa, un trombone, una tromba, un violoncello e un violino, un organo elettrico e un vaso di fiori, ma paiono oggetti insignificanti in confronto a quei pochi elementi illuminati, che sembrano essere lo scorcio di un mondo parallelo. Poi, la ragazza inizia a cantare, ed è subito chiaro che sabato sera non si sono solo dischiuse le porte del teatro, ma anche quelle dei luoghi più intimi della mente di Soap&Skin.
La voce della cantautrice austriaca risuona nel silenzio tombale della platea, che per l’artista, in quel momento, non esiste: le dita si muovono sul pianoforte con la naturalezza di chi, dopo anni carichi di studio, vuole solo alleggerirsi, e con sguardo vitreo, fisso davanti a sé, Anja Franziska Plaschg canta come chi, in estasi, non può farne a meno. “Questa è la fine” sono le parole che segnano l’inizio del brano d’apertura, durante il quale, per ben 8 minuti, il pubblico smette di respirare per non rischiare di interrompere quel gioco di dinamiche, tra grida e quiete, su cui si fonderà l’intero concerto. Soap&Skin sceglie di lasciarci entrare nel suo mondo, ma non ce ne fa essere parte: non c’è sguardo rivolto alla platea, e anche quando implora “can you please help” sulle note di Maybe not, la supplica pare vuota, disperata, da parte di chi, in un teatro vuoto, non ha nessuno a cui chiedere aiuto. A poter sperimentare il suo delirio è solo la piccola orchestra, unica nota di razionalità nella caotica performance: Anja urla, picchia sui tasti, ma gli arrangiamenti orchestrali sono sempre eleganti ed impeccabili.
Anche nei momenti in cui si stacca dal pianoforte, come in God Yu Takem Laef Blong Mi, accompagnata dall’organo, alla platea non è riservata la minima occhiata, e nella sala esistono solo lei e chi con la musica accompagna il suo delicato falsetto.
Ad amplificare l’intimità della performance sono le luci: da un singolo occhio di bue, a dinamici impulsi luminosi, hanno il compito di illuminare chi, in quel momento, partecipa al delirio. In The Sun, attimo di tregua dal caos, un singolo riflettore giallo ricorda il sorgere del sole dopo una notte di incubi.
Il concerto è tanto introspettivo da mettere a disagio, come se origliassimo uno sconosciuto rivelare i suoi segreti più profondi, le sue paure, i suoi peccati. Soap&Skin si permette di interrompersi, iniziare a suonare, fermarsi, sospirare e ricominciare, di lasciare che le si spezzi la voce, di essere imprecisa, perché stiamo esplorando i lati più oscuri della sua mente, dove è lei a dettare le regole.
Con un’Italy da pelle d’oca, dopo quasi un’ora di concerto, arriva la prima, minima, interazione con il pubblico: «Sono contenta di essere qui». Poi si alza, si rivolge alla platea, e tutto cambia: dagli arrangiamenti orchestrali si passa ad elettronica pesante, bassi distorti, voce effettata. Sembra di star assistendo ad un concerto nuovo, opposto al precedente: nella prima metà della serata la cantautrice aveva gridato i mali del mondo e l’angoscia della propria vita, mentre adesso ci guarda dritti negli occhi e ce ne dà la colpa.
Se già prima l’atmosfera era cupa, ora è inquietante: i ritmi sono cadenzati e ricordano i passi di qualcosa di oscuro che si avvicina, magari proprio quelli del Diavolo, con cui Soap&Skin passeggia nella celebre Me and the Devil, e con cui, forse, ha dialogato per tutto il tempo in cui noi, tra il pubblico, non siamo stati considerati.
Abbiamo conosciuto due personalità della stessa artista, o meglio, due personaggi: Soap&Skin balla, cammina per la ribalta, canta appoggiata al pianoforte, e ogni gesto, ogni mimica facciale è teatrale, programmata al dettaglio, al fine di interpretare prima la vittima e poi il carnefice.
Così, non stupisce la scelta di Pale Blue Eyes dei Velvet Underground come bis: torna un singolo occhio di bue ad illuminare una voce sottile, all’apparenza innocente, di chi, se potesse, vorrebbe “rendere il mondo puro”. Sulla coda conclusiva del brano, Anja prende i tulipani da quel vaso che tanto aveva stonato nell’oscurità, e che ora rappresenta quella purezza. Scende dal palco, e distribuisce i fiori tra il pubblico, come se non solo fosse tornata nel nostro mondo, ma volesse ringraziarci per aver lasciato che lei ci presentasse il suo.
Sabato pomeriggio Anja si è messa a nudo e ci ha rivelato di sé probabilmente più di quanto avremmo voluto.
Gli Spiritualized
Chi alle 19:40 ha lasciato il Teatro Regio, con Soap&Skin ha viaggiato tra i pensieri più intimi della mente umana. Chi alle 21 ci è tornato, con gli Spiritualized ha raggiunto persino lo spazio.
Anche qui, in qualche modo si parte dalla fine: ad aprire il concerto è Cop Shoot Cop, da Ladies and gentlemen we are floating in space, chiusura del disco e unico brano della scaletta tratto dal capolavoro del 1997 che ha consacrato il gruppo come vena psichedelica del brit-rock anni ’90. Con il suo riff ipnotico e l’andamento blues, il brano mette subito in chiaro che la band non ha intenzione di guardarsi indietro: aprono, sì, con il più rappresentativo dei loro album, ma se Ladies and gentlemen rappresenta un viaggio, con Cop Shoot Cop gli Spiritualized sono partiti dalla destinazione. Il brano si costruisce tassello dopo tassello, e sale gradualmente proprio come una navicella che si alza in cielo, fino ad aprirsi su una coda tanto potente da farci sentire come se il concerto non fosse appena iniziato, ma, anzi, fosse arrivato al suo gran finale. Se l’intento del gruppo era farci arrivare nel cosmo, Cop Shoot Cop è stato il decollo perfetto: sull’esplosione strumentale finale, Jason Pierce, non a caso detto “Spaceman”, ci annuncia che vi siamo ufficialmente arrivati, e che, sotto gli effetti di quel blister di pasticche presenti sulla copertina dell’album, possiamo allontanarci dai dolori del pianeta Terra e darci a un’allucinazione collettiva fatta di luci stroboscopiche e suoni spaziali. Il trip psichedelico prosegue poi con la spensieratezza di She Kissed Me (It Felt Like a Hit) e Shine a Light, che porta a chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare, abbandonati all’assenza di gravità.
Da questo punto in poi, a dominare la scaletta è Pure Phase, ed è ormai chiaro che si sta assistendo ad un concerto fatto di dinamiche impeccabili, lunghi cori finali e una profonda ricerca timbrica, senza la quale sarebbe impossibile per il gruppo portarci a esplorare l’universo. Il suono è talmente tanto compatto che non c’è neanche bisogno di un frontman a legare il gruppo: Jason Pierce se ne sta in un angolo, con la propria chitarra e lo sguardo fisso sul leggio davanti a sé, e, nonostante il puro rock n’ roll, non si lascia scappare neanche un gesto di spettacolarità. Com’era stato per Soap&Skin, l’interazione col pubblico è minima, se non assente, ma in questo caso tale mancanza si svuota di ogni forma di teatralità: gli Spiritualized hanno eliminato il contingente, per arrivare all’essenza di un concerto in cui a intrattenere il pubblico c’è solo tanta buona musica, suonata da chi fa di arrangiamenti magistrali il proprio punto di forza.
Con gli Spiritualized, anche il Teatro Regio si trasforma: se il palco è vuoto, spoglio di qualsiasi elemento scenografico, giochi di luci e proiezioni di spirali alle pareti fanno sembrare la platea un universo punteggiato di galassie e i palchetti tante piccole capsule spaziali che viaggiano al loro interno.
Dentro, c’è chi passa tutto il concerto in piedi per poter ballare e anche in platea non manca chi si sbraccia e canta a squarcia gola, fino a qualcuno che rappresenta l’incarnazione di Jason Pierce mentre dice di voler «chiudere gli occhi e fluttuare su una nave senza tempo», sulle note di Demaged.
So Long You Pretty Thing, tra i cori e gli abbracci tra il pubblico (e forse qualche lacrima) ricorda a chi si sente il mondo contro che per stare bene basta «continuare a navigare», in questo caso nello spazio, in una coda finale che, sebbene abbia il compito di mettere fine al concerto, probabilmente non ci ha mai davvero riportati con i piedi per Terra.
Con l’accordo conclusivo, però, tutto si ferma e sembra di essere improvvisamente catapultati fuori da un sogno da cui non avremmo voluto svegliarci.
Non c’è bis, né uno sguardo o una mezza parola scambiata col pubblico: come alle 21 in punto si era aperto il sipario, alle 22:30 si richiude, e non saranno i successivi dieci minuti di applausi a convincere la band a concedere un ultimo, agognato, brano. Potremmo dire che gli Spiritualized si sono limitati a svolgere il proprio compito, ma è difficile farne una critica quando lo si è fatto così bene.
I mondi esplorati dalla band non sono tanto cosmici, quanto sonori: dallo shoegaze, al blues, dal progressive all’ambient; se in contemporanea a Bologna suonavano i Radiohead, anche Parma ha saputo ritagliarsi il suo momento di sperimentazione firmato dalla british invasion anni ‘90. In un mondo di concerti evento, irraggiungibili e inaccessibili, Barezzi Festival ha dimostrato che si può ancora promuovere musica perché si crede nel suo valore (non monetario), nel coraggio di sperimentare e nel sostenere chi, fuori dal mainstream, ha fatto comunque parte della sua storia, e, dopo anni di carriera, non solo ha ancora qualcosa da dire, ma, forse, anche da insegnare.